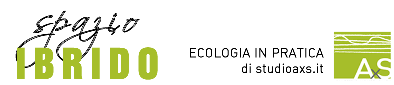Perchè costruire una casa di paglia, quanto dura una casa così realizzata e che caratteristiche ha, questi gli argomenti che cerco di trattare in questo post legato alla pubblicazione di una importante appendice normativa nello stato del Nebraska di cui presto pubblicherò i dettagli.

Casetta di paglia in costruzione ... sotto il sole
Costruire in paglia è una buona alternativa ai metodi tradizionali.
Dire questo in un paese tra i primi produttori al mondo di cemento può apparire una sfida.
In linea generale si pensa che una casa di paglia debba assomigliare a quella dei tre porcellini, cioè poco stabile, in realtà le possibilità di gestione dei cantieri, anche in caso di autocostruzione, permettono di organizzare i materiali e comporre un edifico solido in breve tempo. Ho usato la parola comporre perchè trattandosi di una tecnica di costruzione, prevalentemente a secco, si basa proprio sull'assemblaggio di parti.
Un edificio in balle di paglia è una costruzione architettonica a tutti gli effetti: solida, efficiente, affidabile, confortevole.
La prima tecnica conosciuta risale alla seconda metà dell'800 ed è detta Nebraska, perchè proprio i pionieri americani che si trovavano in quella zona degli Stati Uniti, povera di pietre e legname, iniziarono ad utilizzare le balle di paglia pressata per costruire le loro case. In realtà la tecnica è stata poi modernizzata negli anni '60. In Europa invece il più antico edificio conosciuto, ed ancora in piedi, risale al 1921 e si trova in Francia, ma di fatto solo dagli anni '90 si è riscoperta la tecnica di costruzione in balle di paglia nel nostro continente grazie a Barbara Jones.
Ancora oggi la costruzione si basa sull'uso delle balle di paglia pressata come dei grossi mattoni con i quali comporre le pareti che possono anche essere portanti.
 1921 Maison Feuillet - Francia - Centre National de la Construction Paille Emile Feuillet
1921 Maison Feuillet - Francia - Centre National de la Construction Paille Emile Feuillet
Se stai valutando di costruire la tua casa in paglia, e vuoi capire come farlo allora continua a leggere.
In estrema sintesi si possono avere due tipi di tecniche costruttive: load-bearing cioè portante, dove la paglia svolge anche funzione strutturale; not load-bearing e cioè non portante, dove la paglia è utilizzata come tamponamento di edifici a struttura generalmente di legno.
Nell'ambito delle possibilità costruttive in balle di paglia non portanti esistono vari sistemi che prevedono listellature in legno, a passo più o meno ravvicinato, che possono consentire la posa delle balle sia di piatto, che di taglio e in alcuni casi anche in verticale.
In molti paesi strutture in balle di paglia sono ufficialmente permesse, mentre in Italia si possono costruire case in paglia solamente del tipo non portante, perchè le balle ottenute dalla pressatura e impacchettatura dello scarto di coltivazione dei cereali non è ancora da noi riconosciuto come materiale strutturale. In ogni caso la paglia rimane un'ottima alternativa ai materiali da costruzione tradizionali.
Perchè costruire in paglia?
Queste le caratteristiche intrinseche:
E' leggera e facile da posare – le dimensioni di una balla prismatica sono 35x35x100 cm circa, con variazioni fino a 50x50x120 cm.
E' economica – una balla di paglia costa mediamente da 1 a 3 euro e consente di applicare diffusamente la modalità dell'autocostruione, permettendo di risparmiare moltissimo anche in mano d'opera.
E' ecologica – essendo un prodotto di scarto, usare la paglia significa dare una seconda vita ad un materiale che peraltro è ampiamente diffuso, quindi facile da reperire anche nelle vicinanze del cantiere e che non ha bisogno di lavorazioni aggiuntive.
E' traspirante – questo permette una maggiore salubrità degli ambienti interni.
E' flessibile – caratteristica che rende la paglia idonea anche per costruzioni antisismiche. Le masse di una casa in balle di paglia sono molto inferiori a quelle di un edificio in mattoni o cemento armato, quindi la sollecitazione che incide sulla struttura nel suo complesso è notevolmente inferiore.
E' inattaccabile dai roditori – i topi non si cibano di paglia, tanto meno quando è pressata in balle con densita di almeno 80Kg/mc. Al limite i topi potrebbero essere interessati a fare il nido in un muro di paglia, ma devono prima penetrare l'intonaco che generalmente è in spessore da 3 a 5 cm e ad oggi non è ancora avvenuto.
E' termoisolante – la trasmittanza termica della paglia è 0,06-0,045 W/mqK (variabile a seconda di come vengono disposte le sue fibre), questo rende più facile raggiungere le alte prestazioni richieste dalle ultime normative per il risparmio energetico, ed è perfettamente in linea con i più comuni isolanti naturali usati in edilizia.
E' ad elevato potere fonoassorbente - caratteristica che rende l'uso della paglia ancora più indicato per il comfort interno
E' a basso rischio d'incendio – le prove sperimentali sui materiali per ingegneria civile hanno dimostrato che la estrema densità delle balle di paglia determina la loro resistenza al fuoco. Il fuoco si propaga in presenza di ossigeno, all'interno delle balle questo è presente in scarsa quantità e non è sufficiente per alimentare un incendio. Sembra assurdo ma le costruzioni di paglia possono resistere come, se non più di ogni altra costruzione.
E' capace di immagazzinare la CO2 – considerando l'anidride carbonica emessa in fase di produzione e quella assorbita durante la crescita del cereale si ottiene un valore negativo, cioè la paglia sequestra 1,35 kg di CO2 per ogni Kg di prodotto.
Una volta capito che ci sono molti buoni motivi per costruire una casa in paglia, sicuramente ti stai chiedendo, ma quanto dura?
 2006 Esserhof - Italia - Arch. Schwartz & Shmidt
2006 Esserhof - Italia - Arch. Schwartz & Shmidt
Durata di una casa di paglia
Dato che l'edificio del 1921 costruito in Francia è ancora abitato direi che le costruzioni in paglia possono dare buone garanzie di durata, ovviamente se si rispettano le regole corrette del costruire. Non pensare che siano necessarie grandi opere, già il solo garantire il confinamento delle balle di paglia con un buon strato di intonaco che le protegga dalle intemperie, il prevedere lo stacco da terra di almeno 20/30 cm per non avere il contatto diretto con il terreno e non incorrere così nell'umidità di risalita, il prevedere delle buone sporgenze di gronda per il tetto sono tre azioni sufficienti per garantirsi una buona durabilità.
Ovviamente non si deve trascurare la manutenzione altrimenti le infiltrazioni di acqua e l'umidità possono compromettere gravemente la salute della casa. Già perchè l'acqua è ciò da cui si deve proteggere la paglia, sia quella di infiltrazione che quella dovuta alle condense che si possono sviluppare all'interno delle pareti. Finchè rimane asciutta essa non marcirà e non ci sarà pericolo di sviluppo di muffe, per questo è molto importante preferire intonaci di argilla o calce e non utilizzare intonaci di solo cemento, ma al massimo intonaci di terra e cemento o calce e cemento in modo da mantenere la traspirabilità delle pareti a livelli accettabili. Anche scegliere di intonacare a terra l'interno della casa e usare il cemento all'esterno, per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, può in realtà portare danni peggiori, perchè la diffusione del vapore sarà impedita dall'intonaco esterno favorendo lo sviluppo di condense all'interno del muro.
Cosa fare però nei locali dove si sviluppa più vapore acqueo, tipo bagni, lavanderie o cucine? Qui è possibile e opportuno aumentare la resistenza alla diffusione del vapore dell'intonaco interno aggiungendo olio di lino o membrane a freno vapore sempre posizionate verso l'interno.
Si deve tenere sempre in considerazione che la permeabilità al vapore deve aumentare man mano che si va dall'interno all'esterno della parete, avendo cura di stratificare materiali che permettano la trasmigrazione del vapore verso l'esterno. Ad esempio non si può limitare la verifica del valore [mu] che definisce la permeabilità di un materiale, ma deve essere rapportata anche al suo spessore attraverso un parametro che si chiama Sd e si esprime in metri.
Sempre a titolo di esempio ho preparato questa tabellina che spero ti aiuti a capire meglio:
intonaco terra/argilla (spessore 3 cm) Sd = 0,24 m
intonaco cemento (spessore 2,5cm) Sd = 0,75 m
intonaco calce (spessore 2,5cm) Sd = 0,25 m
paglia (spessore 30 cm) Sd = 0,75 m
Costo di una casa in paglia
Per quello che riguarda il costo devo premettere che ogni caso va valutato attentamente perchè molti sono i fattori che entrano in gioco, come del resto negli altri tipi di costruzione. Ad ogni modo, generalizzando, si può dire che il costo di una casa singola di forma semplice, con struttura in legno e tamponamento in paglia, si aggira intorno ai 1000 euro al mq finita.
 2016 Casa en Casablanca - Cile - Broughton Asociados
2016 Casa en Casablanca - Cile - Broughton Asociados
Conclusioni:
Le case in balle di paglia sono edifici a tutti gli effetti e, per la realizzazione, sono soggette ai permessi autorizzativi ottenibili con la presentazione di un progetto completo firmato da un professionista abilitato, meglio se consapevole e pratico del costruire ecologico.
Per onestà è bene dire che progettare una casa in balle di paglia non è identico al progettare un edificio da costruire con materiali più tradizionali, quindi non si seguono gli stessi principi dell'edilizia convenzionale, un primo punto da tenere in considerazione per esempio è la dimensione e l'altezza dell'edificio che è condizionata dalla modalità con cui si sceglie di posare le balle.
In assenza di una normativa nazionale che indichi le caratteristiche per le balle di paglia da utilizzare in edilizia è possibile fare riferimento alla pratica e alla sperimentazione, ma soprattutto ai codici specifici della California e dell'Arizona, e all'ultima Appendice S pubblicata nello stato del Nebraska che fornisce i requisiti normativi per l'uso delle balle di paglia nelle costruzioni.
Si tratta di indicazioni prestazionali riguardo alla paglia e a tutti gli altri componenti necessari ad ottenere un edificio finito. Questa appendice d'oltre oceano è molto importante perchè norma per la prima volta in modo ufficiale le costruzioni in balle di paglia e affronta il tema dal punto di vista scientifico indicando spessori minimi per paglia e intonaco, dimensioni minime di perni, staffe, rinforzi, collegamenti e quant'altro necessario per la tenuta statica e sismica, fornisce anche le caratteristiche delle finiture ammesse e le composizioni per i vari tipi di intonaco idonei alle costruzioni in paglia, sia che si tratti di strutture autoportanti o solo di tamponamento.
Scarica l'articolo in pdf

Casetta di paglia in costruzione ... sotto il sole
Costruire in paglia è una buona alternativa ai metodi tradizionali.
Dire questo in un paese tra i primi produttori al mondo di cemento può apparire una sfida.
In linea generale si pensa che una casa di paglia debba assomigliare a quella dei tre porcellini, cioè poco stabile, in realtà le possibilità di gestione dei cantieri, anche in caso di autocostruzione, permettono di organizzare i materiali e comporre un edifico solido in breve tempo. Ho usato la parola comporre perchè trattandosi di una tecnica di costruzione, prevalentemente a secco, si basa proprio sull'assemblaggio di parti.
Un edificio in balle di paglia è una costruzione architettonica a tutti gli effetti: solida, efficiente, affidabile, confortevole.
La prima tecnica conosciuta risale alla seconda metà dell'800 ed è detta Nebraska, perchè proprio i pionieri americani che si trovavano in quella zona degli Stati Uniti, povera di pietre e legname, iniziarono ad utilizzare le balle di paglia pressata per costruire le loro case. In realtà la tecnica è stata poi modernizzata negli anni '60. In Europa invece il più antico edificio conosciuto, ed ancora in piedi, risale al 1921 e si trova in Francia, ma di fatto solo dagli anni '90 si è riscoperta la tecnica di costruzione in balle di paglia nel nostro continente grazie a Barbara Jones.
Ancora oggi la costruzione si basa sull'uso delle balle di paglia pressata come dei grossi mattoni con i quali comporre le pareti che possono anche essere portanti.
 1921 Maison Feuillet - Francia - Centre National de la Construction Paille Emile Feuillet
1921 Maison Feuillet - Francia - Centre National de la Construction Paille Emile FeuilletSe stai valutando di costruire la tua casa in paglia, e vuoi capire come farlo allora continua a leggere.
In estrema sintesi si possono avere due tipi di tecniche costruttive: load-bearing cioè portante, dove la paglia svolge anche funzione strutturale; not load-bearing e cioè non portante, dove la paglia è utilizzata come tamponamento di edifici a struttura generalmente di legno.
Nell'ambito delle possibilità costruttive in balle di paglia non portanti esistono vari sistemi che prevedono listellature in legno, a passo più o meno ravvicinato, che possono consentire la posa delle balle sia di piatto, che di taglio e in alcuni casi anche in verticale.
In molti paesi strutture in balle di paglia sono ufficialmente permesse, mentre in Italia si possono costruire case in paglia solamente del tipo non portante, perchè le balle ottenute dalla pressatura e impacchettatura dello scarto di coltivazione dei cereali non è ancora da noi riconosciuto come materiale strutturale. In ogni caso la paglia rimane un'ottima alternativa ai materiali da costruzione tradizionali.
Perchè costruire in paglia?
Queste le caratteristiche intrinseche:
E' leggera e facile da posare – le dimensioni di una balla prismatica sono 35x35x100 cm circa, con variazioni fino a 50x50x120 cm.
E' economica – una balla di paglia costa mediamente da 1 a 3 euro e consente di applicare diffusamente la modalità dell'autocostruione, permettendo di risparmiare moltissimo anche in mano d'opera.
E' ecologica – essendo un prodotto di scarto, usare la paglia significa dare una seconda vita ad un materiale che peraltro è ampiamente diffuso, quindi facile da reperire anche nelle vicinanze del cantiere e che non ha bisogno di lavorazioni aggiuntive.
E' traspirante – questo permette una maggiore salubrità degli ambienti interni.
E' flessibile – caratteristica che rende la paglia idonea anche per costruzioni antisismiche. Le masse di una casa in balle di paglia sono molto inferiori a quelle di un edificio in mattoni o cemento armato, quindi la sollecitazione che incide sulla struttura nel suo complesso è notevolmente inferiore.
E' inattaccabile dai roditori – i topi non si cibano di paglia, tanto meno quando è pressata in balle con densita di almeno 80Kg/mc. Al limite i topi potrebbero essere interessati a fare il nido in un muro di paglia, ma devono prima penetrare l'intonaco che generalmente è in spessore da 3 a 5 cm e ad oggi non è ancora avvenuto.
E' termoisolante – la trasmittanza termica della paglia è 0,06-0,045 W/mqK (variabile a seconda di come vengono disposte le sue fibre), questo rende più facile raggiungere le alte prestazioni richieste dalle ultime normative per il risparmio energetico, ed è perfettamente in linea con i più comuni isolanti naturali usati in edilizia.
E' ad elevato potere fonoassorbente - caratteristica che rende l'uso della paglia ancora più indicato per il comfort interno
E' a basso rischio d'incendio – le prove sperimentali sui materiali per ingegneria civile hanno dimostrato che la estrema densità delle balle di paglia determina la loro resistenza al fuoco. Il fuoco si propaga in presenza di ossigeno, all'interno delle balle questo è presente in scarsa quantità e non è sufficiente per alimentare un incendio. Sembra assurdo ma le costruzioni di paglia possono resistere come, se non più di ogni altra costruzione.
E' capace di immagazzinare la CO2 – considerando l'anidride carbonica emessa in fase di produzione e quella assorbita durante la crescita del cereale si ottiene un valore negativo, cioè la paglia sequestra 1,35 kg di CO2 per ogni Kg di prodotto.
Una volta capito che ci sono molti buoni motivi per costruire una casa in paglia, sicuramente ti stai chiedendo, ma quanto dura?
 2006 Esserhof - Italia - Arch. Schwartz & Shmidt
2006 Esserhof - Italia - Arch. Schwartz & ShmidtDurata di una casa di paglia
Dato che l'edificio del 1921 costruito in Francia è ancora abitato direi che le costruzioni in paglia possono dare buone garanzie di durata, ovviamente se si rispettano le regole corrette del costruire. Non pensare che siano necessarie grandi opere, già il solo garantire il confinamento delle balle di paglia con un buon strato di intonaco che le protegga dalle intemperie, il prevedere lo stacco da terra di almeno 20/30 cm per non avere il contatto diretto con il terreno e non incorrere così nell'umidità di risalita, il prevedere delle buone sporgenze di gronda per il tetto sono tre azioni sufficienti per garantirsi una buona durabilità.
Ovviamente non si deve trascurare la manutenzione altrimenti le infiltrazioni di acqua e l'umidità possono compromettere gravemente la salute della casa. Già perchè l'acqua è ciò da cui si deve proteggere la paglia, sia quella di infiltrazione che quella dovuta alle condense che si possono sviluppare all'interno delle pareti. Finchè rimane asciutta essa non marcirà e non ci sarà pericolo di sviluppo di muffe, per questo è molto importante preferire intonaci di argilla o calce e non utilizzare intonaci di solo cemento, ma al massimo intonaci di terra e cemento o calce e cemento in modo da mantenere la traspirabilità delle pareti a livelli accettabili. Anche scegliere di intonacare a terra l'interno della casa e usare il cemento all'esterno, per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, può in realtà portare danni peggiori, perchè la diffusione del vapore sarà impedita dall'intonaco esterno favorendo lo sviluppo di condense all'interno del muro.
Cosa fare però nei locali dove si sviluppa più vapore acqueo, tipo bagni, lavanderie o cucine? Qui è possibile e opportuno aumentare la resistenza alla diffusione del vapore dell'intonaco interno aggiungendo olio di lino o membrane a freno vapore sempre posizionate verso l'interno.
Si deve tenere sempre in considerazione che la permeabilità al vapore deve aumentare man mano che si va dall'interno all'esterno della parete, avendo cura di stratificare materiali che permettano la trasmigrazione del vapore verso l'esterno. Ad esempio non si può limitare la verifica del valore [mu] che definisce la permeabilità di un materiale, ma deve essere rapportata anche al suo spessore attraverso un parametro che si chiama Sd e si esprime in metri.
Sempre a titolo di esempio ho preparato questa tabellina che spero ti aiuti a capire meglio:
intonaco terra/argilla (spessore 3 cm) Sd = 0,24 m
intonaco cemento (spessore 2,5cm) Sd = 0,75 m
intonaco calce (spessore 2,5cm) Sd = 0,25 m
paglia (spessore 30 cm) Sd = 0,75 m
Costo di una casa in paglia
Per quello che riguarda il costo devo premettere che ogni caso va valutato attentamente perchè molti sono i fattori che entrano in gioco, come del resto negli altri tipi di costruzione. Ad ogni modo, generalizzando, si può dire che il costo di una casa singola di forma semplice, con struttura in legno e tamponamento in paglia, si aggira intorno ai 1000 euro al mq finita.
 2016 Casa en Casablanca - Cile - Broughton Asociados
2016 Casa en Casablanca - Cile - Broughton AsociadosConclusioni:
Le case in balle di paglia sono edifici a tutti gli effetti e, per la realizzazione, sono soggette ai permessi autorizzativi ottenibili con la presentazione di un progetto completo firmato da un professionista abilitato, meglio se consapevole e pratico del costruire ecologico.
Per onestà è bene dire che progettare una casa in balle di paglia non è identico al progettare un edificio da costruire con materiali più tradizionali, quindi non si seguono gli stessi principi dell'edilizia convenzionale, un primo punto da tenere in considerazione per esempio è la dimensione e l'altezza dell'edificio che è condizionata dalla modalità con cui si sceglie di posare le balle.
In assenza di una normativa nazionale che indichi le caratteristiche per le balle di paglia da utilizzare in edilizia è possibile fare riferimento alla pratica e alla sperimentazione, ma soprattutto ai codici specifici della California e dell'Arizona, e all'ultima Appendice S pubblicata nello stato del Nebraska che fornisce i requisiti normativi per l'uso delle balle di paglia nelle costruzioni.
Si tratta di indicazioni prestazionali riguardo alla paglia e a tutti gli altri componenti necessari ad ottenere un edificio finito. Questa appendice d'oltre oceano è molto importante perchè norma per la prima volta in modo ufficiale le costruzioni in balle di paglia e affronta il tema dal punto di vista scientifico indicando spessori minimi per paglia e intonaco, dimensioni minime di perni, staffe, rinforzi, collegamenti e quant'altro necessario per la tenuta statica e sismica, fornisce anche le caratteristiche delle finiture ammesse e le composizioni per i vari tipi di intonaco idonei alle costruzioni in paglia, sia che si tratti di strutture autoportanti o solo di tamponamento.
Rodolfo Collodi Architetto
Scarica l'articolo in pdf