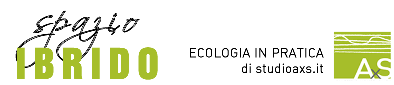La concezione solare passiva prevede l'integrazione nella struttura di
elementi captanti, che possono essere a guadagno diretto – come finestre
solari e serre solari convettive – o a guadagno indiretto – come serre
solari di accumulo, muro di Trombe-Michelle, accumuli isolati .
L'accumulo solare isolato è un sistema di captazione passiva dell'energia solare che abbiamo costruito in Perù per il progetto Inti Yatrai Wasi. Si tratta di un dispositivo bioclimatico che garantisce un guadagno indiretto, utile per riscaldare l'interno del locale laboratorio.

Trovandoci in una zona di estrema povertà ci siamo chiesti come fosse possibile raggiungere le migliori condizioni di comfort, sfruttando gratuitamente le risorse locali e senza impoverire il contesto.
Partendo dalla convinzione che alcune funzioni, spesso demandate agli impianti, possono essere trasferite all'edificio, pensandolo come un organismo che interagisce con il cambiamento delle condizioni climatiche, abbiamo valutato, attraverso simulazioni, alcune soluzioni di sfruttamento passivo solare che fossero integrate nella costruzione. In pratica abbiamo lavorato per rendere il più possibile efficiente l'edificio che stavamo costruendo attraverso interventi strutturali e non impiantistici.
Come funziona l'accumulo solare isolato.
Il trasferimento di energia dal collettore all'ambiente o all'accumulo, e dall'accumulo all'ambiente avviene solo attraverso la convezione e l'irraggiamento.
L'accumulo deve essere composto da: una camera esterna, esposta al sole, in cui viene scaldata l'aria; un accumulo per immagazzinare il calore prodotto; un sistema di distribuzione dell'aria scaldata.
L'aria riscaldata nel collettore, diventa meno densa, tende a spostarsi verso l'alto mettendosi in movimento; l'aria più calda trasferisce la sua energia all'accumulo isolato o direttamente alla stanza, qui si raffredda e ricade per essere ripresa dal collettore. Il ciclo continua fintanto che il collettore rimane sufficientemente caldo.

Come lo abbiamo realizzato con materiali facili da trovare e a basso costo.
All'esterno del laboratorio Inti Yatrai Wasi è stata predisposta una camera, cioè uno spazio cuscinetto, dove l'aria viene riscaldata grazie all'apporto solare che attraversa uno strato trasparente (lastre di resina ondulata e/o pellicola di plastica) ed il cui effetto è amplificato grazie alla presenza di una lamiera di base dipinta di nero, posata in due strati con interposto uno strato di terra, per aumentare l'inerzia (accorgimento utile in caso di cielo coperto).

Trovandoci in una zona di estrema povertà ci siamo chiesti come fosse possibile raggiungere le migliori condizioni di comfort, sfruttando gratuitamente le risorse locali e senza impoverire il contesto.
Partendo dalla convinzione che alcune funzioni, spesso demandate agli impianti, possono essere trasferite all'edificio, pensandolo come un organismo che interagisce con il cambiamento delle condizioni climatiche, abbiamo valutato, attraverso simulazioni, alcune soluzioni di sfruttamento passivo solare che fossero integrate nella costruzione. In pratica abbiamo lavorato per rendere il più possibile efficiente l'edificio che stavamo costruendo attraverso interventi strutturali e non impiantistici.
Come funziona l'accumulo solare isolato.
Il trasferimento di energia dal collettore all'ambiente o all'accumulo, e dall'accumulo all'ambiente avviene solo attraverso la convezione e l'irraggiamento.
L'accumulo deve essere composto da: una camera esterna, esposta al sole, in cui viene scaldata l'aria; un accumulo per immagazzinare il calore prodotto; un sistema di distribuzione dell'aria scaldata.
L'aria riscaldata nel collettore, diventa meno densa, tende a spostarsi verso l'alto mettendosi in movimento; l'aria più calda trasferisce la sua energia all'accumulo isolato o direttamente alla stanza, qui si raffredda e ricade per essere ripresa dal collettore. Il ciclo continua fintanto che il collettore rimane sufficientemente caldo.

Come lo abbiamo realizzato con materiali facili da trovare e a basso costo.
All'esterno del laboratorio Inti Yatrai Wasi è stata predisposta una camera, cioè uno spazio cuscinetto, dove l'aria viene riscaldata grazie all'apporto solare che attraversa uno strato trasparente (lastre di resina ondulata e/o pellicola di plastica) ed il cui effetto è amplificato grazie alla presenza di una lamiera di base dipinta di nero, posata in due strati con interposto uno strato di terra, per aumentare l'inerzia (accorgimento utile in caso di cielo coperto).
All'interno del fabbricato è stato creato un solaio comprendente, dal basso verso l'alto: un sistema di canali di distribuzione dell'aria, in modo da garantire uno scambio diretto con il locale laboratorio da riscaldare, realizzati con mattoni cotti perchè posti a contatto con il terreno; un soprastante strato di accumulo con pietre miste che invece garantisce la possibilità di sfruttare l'inerzia del materiale per immagazzinare il calore rilasciato dall'aria e poterlo poi sfruttare in orari serali; un pavimento in tavole di legno sostenute da una struttura lignea leggera, posata in modo da non essere a contatto con il letto di pietre.
Le pietre sono contenute da una rete in modo da permettere la massima permeabilità all'aria.
La camera esterna è collegata agli strati del solaio attraverso condotti in plastica che attraversano il muro perimetrale, posti sia a livello delle canalizzazioni in basso che a quello dell'intercapedine tra letto di pietre e pavimento.
All'interno del locale laboratorio sono presenti delle griglie a pavimento che possono essere regolate manualmente per permettere l'ingresso di aria calda direttamente dal collettore o per agevolare il ricircolo dell'aria attraverso il letto di pietre.

(tutte le immagini in questi mix sono di Valentina Bonetti)
Da una verifica empirica in loco il dispositivo funziona molto bene ed ha già destato l'interesse dei lavoratori presenti. Purtroppo, per problemi locali nello sviluppo del progetto non è possibile proseguire con l'azione di monitoraggio prevista.
Le pietre sono contenute da una rete in modo da permettere la massima permeabilità all'aria.
La camera esterna è collegata agli strati del solaio attraverso condotti in plastica che attraversano il muro perimetrale, posti sia a livello delle canalizzazioni in basso che a quello dell'intercapedine tra letto di pietre e pavimento.
All'interno del locale laboratorio sono presenti delle griglie a pavimento che possono essere regolate manualmente per permettere l'ingresso di aria calda direttamente dal collettore o per agevolare il ricircolo dell'aria attraverso il letto di pietre.

(tutte le immagini in questi mix sono di Valentina Bonetti)
Da una verifica empirica in loco il dispositivo funziona molto bene ed ha già destato l'interesse dei lavoratori presenti. Purtroppo, per problemi locali nello sviluppo del progetto non è possibile proseguire con l'azione di monitoraggio prevista.
Giulia Bertolucci architetto