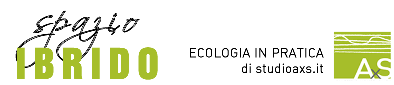Se ti trovi in uno di questi casi non puoi non valutare l'opportunità di fare una fitodepurazione delle tue acque di scarico per poterle reimmettere nell'ambiente senza doverti collegare alla fognatura pubblica!

E' incredibile ma ancora una volta la natura ci viene incontro per metabolizzare le nostre schifezze.
Già nell'antichità si era a conoscenza della capacità delle piante di influire sulla qualità delle acque e di ridurre una parte degli inquinanti presenti. Purtroppo i corsi d'acqua e le zone lagunari o gli stagni erano anche portatori di insetti e per questo sono stati ritenuti zone poco salubri, da bonificare. Oggi però abbiamo compreso realmente quanto efficaci possono essere le piante per la depurazione delle acque. Esse permettono di ridurre le quantità di inquinanti dovute al metabolismo umano e di reimmettere in ambiente delle acque depurate, spesso in modo migliore rispetto a quelle ottenute con i classici depuratori.
Ma la fitodepurazione si può usare solo in aperta campagna?
No, infatti esistono interi quartieri e paesi e città che depurano in modo ecologico le proprie acque di scarico grazie all’utilizzo delle piante. Ecolonia oppure Berlino possono essere buoni esempi. L'intero quartiere di Potsdamerplaz (di cui vedi le foto in questo post) realizzato in ampliamento della capitale tedesca ha un sistema di lagunaggio, integrato con gli edifici e con gli spazi pubblici, per l'affinamento delle acque raccolte. Queste una volta depurate e rivitalizzate attraverso fontane, vengono riutilizzate per irrigazione e altri usi compatibili, infine reimmessa nel fiume Sprea.

Ma è difficile realizzare un impianto per depurare le acque di scarico in modo ecologico?
La risposta è sostanzialmente NO, ma si devono applicare degli accorgimenti per fare in modo che tutto funzioni. Tutto questo vale ovviamente se lo vuoi realizzare in autonomia. Nel caso contrario hai due possibilità: la prima è chiamare una ditta specializzata che farà tutto il lavoro, la seconda è acquistare un kit con tutti i componenti.
Per decidere quale strada seguire (autocostruire o appaltare) ti può essere utile sapere in cosa consiste una fitodepurazione.
Brevemente, dato che in rete si trovano già molte informazioni, posso dire che un impianto di fitodepurazione è un sistema abbastanza semplice in cui il connubio tra suolo e piante permette di sviluppare condizioni ideali per i processi depurativi, riproducendo quello che avviene in maniera naturale. Si tratta di un letto ottenuto tramite uno scavo impermeabilizzato con un telo (tipo polietilene ad alta densità) o con bentonite sodica, su cui viene disposto e livellato uno strato di ghiaia di varia pezzatura, il più possibile permeabile all’acqua e ai liquidi, in cui le piante sono messe a dimora, risultando con le radici immerse. In questo tipo di impianto il refluo percola attraverso la ghiaia fino alla base delle radici e, grazie ad un legame sia fisico che chimico con gli inerti, sia alle piante, sia ai batteri che si sviluppano nell'apparato radicale, viene filtrato, depurato e reimmesso in ambiente.
L’efficacia depurativa delle piante è data sia dall'assorbimento di alcuni inquinanti, sia perché riescono a mantenere permeabile il substrato permettendo lo sviluppo di batteri aerobici in grado di depurare la maggior parte degli inquinanti.
 schemi: sopra sistema flusso superficiale; sotto sistema a flusso sommerso
schemi: sopra sistema flusso superficiale; sotto sistema a flusso sommerso Per quanto riguarda le tecniche di fitodepurazione esistono diversi sistemi classificati a seconda di come il refluo entra e scorre nell'impianto e della tipologia di piante. Si tratta di sistemi a macrofite galleggianti o radicate, che a loro volta si dividono in due gruppi: a macrofite radicate sommerse o emergenti.
In base allo scorrimento del refluo quelli che garantiscono una minore efficacia nel trattamento depurativo sono i sistemi a flusso superficiale libero (ad esempio piccoli laghi, o letti di fitodepurazione in cui il liquido passa in superficie), che possono anche portare insetti; maggiore efficacia invece hanno quelli a flusso sommerso, sia orizzontale che verticale, che necessitano inoltre di minor spazio.
Nei sistemi a flusso sommerso il refluo entra nell'area di fitodepurazione, passa tra le radici delle piante (senza sviluppare cattivi odori o attirare insetti), attraversa tutto il letto (scorrendo orizzontalmente o percolando verticalmente) e fuoriesce depurato con un abbattimento di BOD, COD, SS, N e P.
Come è facile da immaginare anche la scelta delle piante è importante ai fini della riuscita e dell'efficacia dell'impianto.
A grandi linee i criteri per la selezione delle piante più adatte si possono riassumere in:
- adattabilità al clima locale e resistenza ad eventuali condizioni avverse,
- elevata attività di fotosintesi,
- elevata capacità di trasporto dell'ossigeno,
- resistenza alle concentrazioni elevate di inquinanti e capacità di assimilazione degli stessi,
- resistenza alle malattie,
- semplicità di coltivazione e gestione.
La pianta più diffusa e utilizzata per la depurazione è la canna palustre, molto resistente, facile da trovare sul territorio (è addirittura considerata pianta infestante), caratterizzata anche dalla capacità di portare molto ossigeno alle radici.
Le altre specie sono ad esempio il giunco di palude, oppure la mazza sorda, o ancora la lenticchia d’acqua, quest'ultima si incontra spesso in bacini o fossi ed è efficace soprattutto per la depurazione dei metalli pesanti. In realtà, nel momento in cui il letto di depurazione dovesse essere anche decorativo, ad esempio quando è vicino o integrato all'abitato, è possibile utilizzare piante idonee alla depurazione e anche ornamentali, che offrono fioriture da marzo a ottobre, come l'iris d'acqua, la canna indica, la talia dealbata, la menta d'acqua, il giacinto d'acqua, la calla,ecc.

Questa tipologia di impianto può essere utilizzato sia come trattamento secondario, posto a valle di un trattamento primario che preveda una sedimentazione del refluo e un degrassamento, oppure come trattamento terziario a valle di impianti di depurazione tradizionali in cui l'effluente non raggiunge i limiti imposti dalla normativa.
A seguito di un trattamento di fitodepurazione il refluo è depurato, la sua qualità rientra sicuramente nella tabella 4 del D. Lgs 152/2006 e pertanto può essere raccolto per l'uso in irrigazione, oppure può essere conferito in corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, fosse vicinali ecc), o disperso nel terreno.
Come si dimensiona l'impianto di fitodepurazione?
La progettazione, nonostante l'apparente semplicità, necessita di attenzioni sia per evitare il verificarsi di corto circuito o intasamento idraulico, sia per assicurarsi che il refluo rimanga nel letto almeno una settimana e non passi velocemente andando allo scarico prima dei tempi necessari.
Per quello che riguarda il dimensionamento dei letti per la depurazione naturale esistono delle indicazioni da seguire, diverse a seconda che si tratti di impianti a flusso superficiale o a flusso sommerso. In linea generale si può dire che la superficie minima per il corretto funzionamento è di 20 mq, anche se per il flusso sommerso si può dettagliare meglio in base alla tipologia di scorrimento del refluo. In caso di flusso orizzontale si devono prevedere 5 mq per ogni abitante equivalente, mentre per quello verticale 4 mq ad abitante equivalente. In realtà incidono sul dimensionamento anche la frequenza di utilizzo dell'impianto, cioè se deve servire delle residenze costanti oppure solo stagionali. Mentre per quanto riguarda la profondità del letto influisce sicuramente la tipologia di piante che si scelgono; c'è una ricca letteratura in merito, ma anche qui volendo dare una indicazione generale possono essere giusti dai 70-80 cm e oltre.
Conclusione:
L'impianto di depurazione ecologico si può integrare perfettamente sia in contesti bucolici che urbani. Le piante, se scelte e collocate correttamente, non devono essere rimpiazzate o sostituite, e per il corretto funzionamento non sono necessari apporti elettrici, riducendo così anche i costi di gestione relativi solo alle sporadiche manutenzioni.
Scegliere di depurare con sistemi ecologici non è solo per chi ha stili di vita alternativi, ma lo stesso D.Lgs 152/2006 - Testo Unico sull'Ambiente considera gli impianti di fitodepurazione come trattamento appropriato degli scarichi e promuove il ricorso alla depurazione naturale sia per agglomerati fino a 200 abitanti equivalenti, sia per agglomerati fino a 25000 abitanti equivalenti, in questo secondo caso come trattamento di affinamento.
Rodolfo Collodi architetto
Per approfondimenti ti consiglio la Guida ISPRA