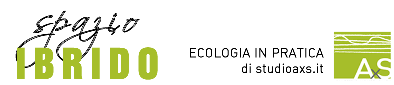E' primavera e stai pensando di rinfrescare la tua casa con una nuova pittura per interni? Le pareti sono un po' segnate dal passare del tempo? Il bianco si è ingrigito? Questo articolo ti sarà utile per sapere quale prodotto scegliere.
Sicuramente hai pensato al colore. Magari un nuovo bianco che non sia però troppo candido per avere un'atmosfera più accogliente. Oppure qualche tocco di colore per ravvivare le stanze o per accentuare dettagli. E poi avrai forse anche pensato al tipo di pittura da interni: traspirante oppure lavabile, con finitura satinata, o addirittura scrivibile per la cameretta dei bambini.
Ma c'è un altro elemento fondamentale a cui fare attenzione nella scelta di una pittura da interni: la composizione. Perché le pitture non sono tutte uguali.
Esistono sostanze chimiche, che possono essere contenute nelle pitture e nelle vernici, che tendono ad evaporare facilmente a temperatura ambiente provocando disturbi.

Hai dei bambini? A maggior ragione devi porre attenzione allle caratteristiche delle pitture da interni perché i piccoli sono più sensibili, come del resto anche gli anziani.
Il problema maggiore si ha in presenza di contenuto di formaldeide perché questa viene rilasciata anche per anni dopo la posa. Nonostante questo aspetto critico purtroppo la formaldeide è spesso usata come conservante delle pitture, grazie alla sua economicità.
Per quello che riguarda invece altre sostanze si può dire che la tossicità varia a seconda della composizione, ma in linea generale si ha un'emissione maggiore di sostanze nocive all'inizio, cioè subito dopo la posa, e una progressiva diminuzione nel tempo.
Non credere però che basti arieggiare la casa per qualche giorno per risolvere il problema, perché la durata di questa emissione varia a seconda del composto chimico utilizzato e può essere anche di 6 mesi e oltre.
Se vuoi tinteggiare la casa e continuare a viverci devi assolutamente scegliere pitture da interni che ti garantiscano la salubrità.

Una persona che non vedevo da tempo recentemente mi ha raccontato una sua esperienza che mi pare significativa a proposito di tinteggiare casa.
Ti racconto di Maria che, impegnata spesso in lavori fuori sede, ha approfittato di un periodo in cui non avrebbe avuto bisogno della casa per rinnovare la pittura della camera e dello studio.
Per lavoro lei si è spesso trovata ad affrontare il tema della salubrità dei luoghi di lavoro quindi, consapevole che le vernici non sono tutte uguali e che spesso possono dare disturbi, Maria si è rivolta con fiducia alla sua impresa di imbiancature chiedendo consiglio, non tanto sul colore, quanto proprio sul tipo di pittura murale da usare per evitare di andare incontro a situazioni spiacevoli.
Rassicurata circa i suoi dubbi ha lasciato casa nelle mani dell'impresa. Al suo ritorno il lavoro era perfetto, ma Maria ha sentito subito la necessità di arieggiare. L'odore della pittura era troppo penetrante, fortuna che ottobre permette ancora di stare con le finestre aperte per lungo tempo.
Dopo mesi però Maria ha capito che il problema non è l'odore di quella pittura all'acqua, ormai fortunatamente svanito, ma deve per forza esserci qualcos'altro dato che quando passa qualche giorno in più a casa le si presenta un pizzicore alla gola.
Ed è a questo punto che ci incontriamo e mi racconta questa storia. Le spiego così che il fatto che la vernice sia all'acqua non è garanzia di assenza di tossicità, perché anche le pitture all'acqua possono contenere sostanze irritanti per le mucose o per le vie respiratorie. Ci sono infatti varie sostanze che vengono utilizzate per migliorare l'aspetto della vernice, la velocità di essiccazione, la facilità di posa, che possono essere tossiche seppure ammesse dalla normativa.
Insomma le vernici all'acqua sono certamente meno pericolose, ma non del tutto innocue, come spesso invece viene sostenuto anche dai posatori.
Nel caso di Maria nonostante tutte le cautele, il prodotto che è stato consigliato evidentemente non è esente da emissioni tossiche. Certamente è possibile che lei stessa sia particolarmente sensibile. Sta di fatto però che, come è spiegato dettagliatamente nell'articolo “Le vernici all'acqua sono innocue?” , fidarsi solo del fatto che le pitture sono all'acqua non ne garantisce la totale innocuità.

Conclusioni
E' possibile che non ti capiti mai di avvertire un malessere a causa di una tinteggiatura, ma è anche possibile che tu abbia una tosse di cui non riesci a capire la causa. Indagare meglio le condizioni degli ambienti in cui trascorri la maggior parte del tempo può essere una buona pista da seguire.
La parte più difficile è sempre trovare il prodotto giusto, nella moltitudine di quelli offerti dal mercato, che sia sicuro in relazione alle emissioni di composti organici volatili tossici per inalazione. Un modo per avere maggiori garanzie di bontà di una pittura o vernice dal punto di vista delle esalazioni è cercare il marchio EC1 di cui si è parlato in questo articolo, oppure potresti cercare un altro simbolo che deve essere riportato sulle confezioni: A+. Questo fa riferimento ad un sistema di marcatura obbligatoria in Francia, ma che si può trovare sulle confezioni delle pitture da interni commercializzate anche nei centri fai da te in Italia (dove invece l'obbligatorietà non c'è).
In generale però le ditte hanno anche altri modi per dichiarare che il contenuto delle pitture sia esente o a basso contenuto di VOC e che non fanno riferimento a marcature specifiche.
Per questo è sempre opportuno andare a vedere il contenuto, cioè la composizione della pittura che si vuole usare, per capire se può essere più o meno fonte di emissioni dannose per la salute.
Giulia Bertolucci architetto
Sicuramente hai pensato al colore. Magari un nuovo bianco che non sia però troppo candido per avere un'atmosfera più accogliente. Oppure qualche tocco di colore per ravvivare le stanze o per accentuare dettagli. E poi avrai forse anche pensato al tipo di pittura da interni: traspirante oppure lavabile, con finitura satinata, o addirittura scrivibile per la cameretta dei bambini.
Ma c'è un altro elemento fondamentale a cui fare attenzione nella scelta di una pittura da interni: la composizione. Perché le pitture non sono tutte uguali.
Esistono sostanze chimiche, che possono essere contenute nelle pitture e nelle vernici, che tendono ad evaporare facilmente a temperatura ambiente provocando disturbi.

Hai dei bambini? A maggior ragione devi porre attenzione allle caratteristiche delle pitture da interni perché i piccoli sono più sensibili, come del resto anche gli anziani.
Il problema maggiore si ha in presenza di contenuto di formaldeide perché questa viene rilasciata anche per anni dopo la posa. Nonostante questo aspetto critico purtroppo la formaldeide è spesso usata come conservante delle pitture, grazie alla sua economicità.
Per quello che riguarda invece altre sostanze si può dire che la tossicità varia a seconda della composizione, ma in linea generale si ha un'emissione maggiore di sostanze nocive all'inizio, cioè subito dopo la posa, e una progressiva diminuzione nel tempo.
Non credere però che basti arieggiare la casa per qualche giorno per risolvere il problema, perché la durata di questa emissione varia a seconda del composto chimico utilizzato e può essere anche di 6 mesi e oltre.
Se vuoi tinteggiare la casa e continuare a viverci devi assolutamente scegliere pitture da interni che ti garantiscano la salubrità.

Una persona che non vedevo da tempo recentemente mi ha raccontato una sua esperienza che mi pare significativa a proposito di tinteggiare casa.
Ti racconto di Maria che, impegnata spesso in lavori fuori sede, ha approfittato di un periodo in cui non avrebbe avuto bisogno della casa per rinnovare la pittura della camera e dello studio.
Per lavoro lei si è spesso trovata ad affrontare il tema della salubrità dei luoghi di lavoro quindi, consapevole che le vernici non sono tutte uguali e che spesso possono dare disturbi, Maria si è rivolta con fiducia alla sua impresa di imbiancature chiedendo consiglio, non tanto sul colore, quanto proprio sul tipo di pittura murale da usare per evitare di andare incontro a situazioni spiacevoli.
Rassicurata circa i suoi dubbi ha lasciato casa nelle mani dell'impresa. Al suo ritorno il lavoro era perfetto, ma Maria ha sentito subito la necessità di arieggiare. L'odore della pittura era troppo penetrante, fortuna che ottobre permette ancora di stare con le finestre aperte per lungo tempo.
Dopo mesi però Maria ha capito che il problema non è l'odore di quella pittura all'acqua, ormai fortunatamente svanito, ma deve per forza esserci qualcos'altro dato che quando passa qualche giorno in più a casa le si presenta un pizzicore alla gola.
Ed è a questo punto che ci incontriamo e mi racconta questa storia. Le spiego così che il fatto che la vernice sia all'acqua non è garanzia di assenza di tossicità, perché anche le pitture all'acqua possono contenere sostanze irritanti per le mucose o per le vie respiratorie. Ci sono infatti varie sostanze che vengono utilizzate per migliorare l'aspetto della vernice, la velocità di essiccazione, la facilità di posa, che possono essere tossiche seppure ammesse dalla normativa.
Insomma le vernici all'acqua sono certamente meno pericolose, ma non del tutto innocue, come spesso invece viene sostenuto anche dai posatori.
Nel caso di Maria nonostante tutte le cautele, il prodotto che è stato consigliato evidentemente non è esente da emissioni tossiche. Certamente è possibile che lei stessa sia particolarmente sensibile. Sta di fatto però che, come è spiegato dettagliatamente nell'articolo “Le vernici all'acqua sono innocue?” , fidarsi solo del fatto che le pitture sono all'acqua non ne garantisce la totale innocuità.

Conclusioni
E' possibile che non ti capiti mai di avvertire un malessere a causa di una tinteggiatura, ma è anche possibile che tu abbia una tosse di cui non riesci a capire la causa. Indagare meglio le condizioni degli ambienti in cui trascorri la maggior parte del tempo può essere una buona pista da seguire.
La parte più difficile è sempre trovare il prodotto giusto, nella moltitudine di quelli offerti dal mercato, che sia sicuro in relazione alle emissioni di composti organici volatili tossici per inalazione. Un modo per avere maggiori garanzie di bontà di una pittura o vernice dal punto di vista delle esalazioni è cercare il marchio EC1 di cui si è parlato in questo articolo, oppure potresti cercare un altro simbolo che deve essere riportato sulle confezioni: A+. Questo fa riferimento ad un sistema di marcatura obbligatoria in Francia, ma che si può trovare sulle confezioni delle pitture da interni commercializzate anche nei centri fai da te in Italia (dove invece l'obbligatorietà non c'è).
In generale però le ditte hanno anche altri modi per dichiarare che il contenuto delle pitture sia esente o a basso contenuto di VOC e che non fanno riferimento a marcature specifiche.
Per questo è sempre opportuno andare a vedere il contenuto, cioè la composizione della pittura che si vuole usare, per capire se può essere più o meno fonte di emissioni dannose per la salute.
Giulia Bertolucci architetto